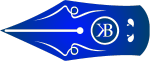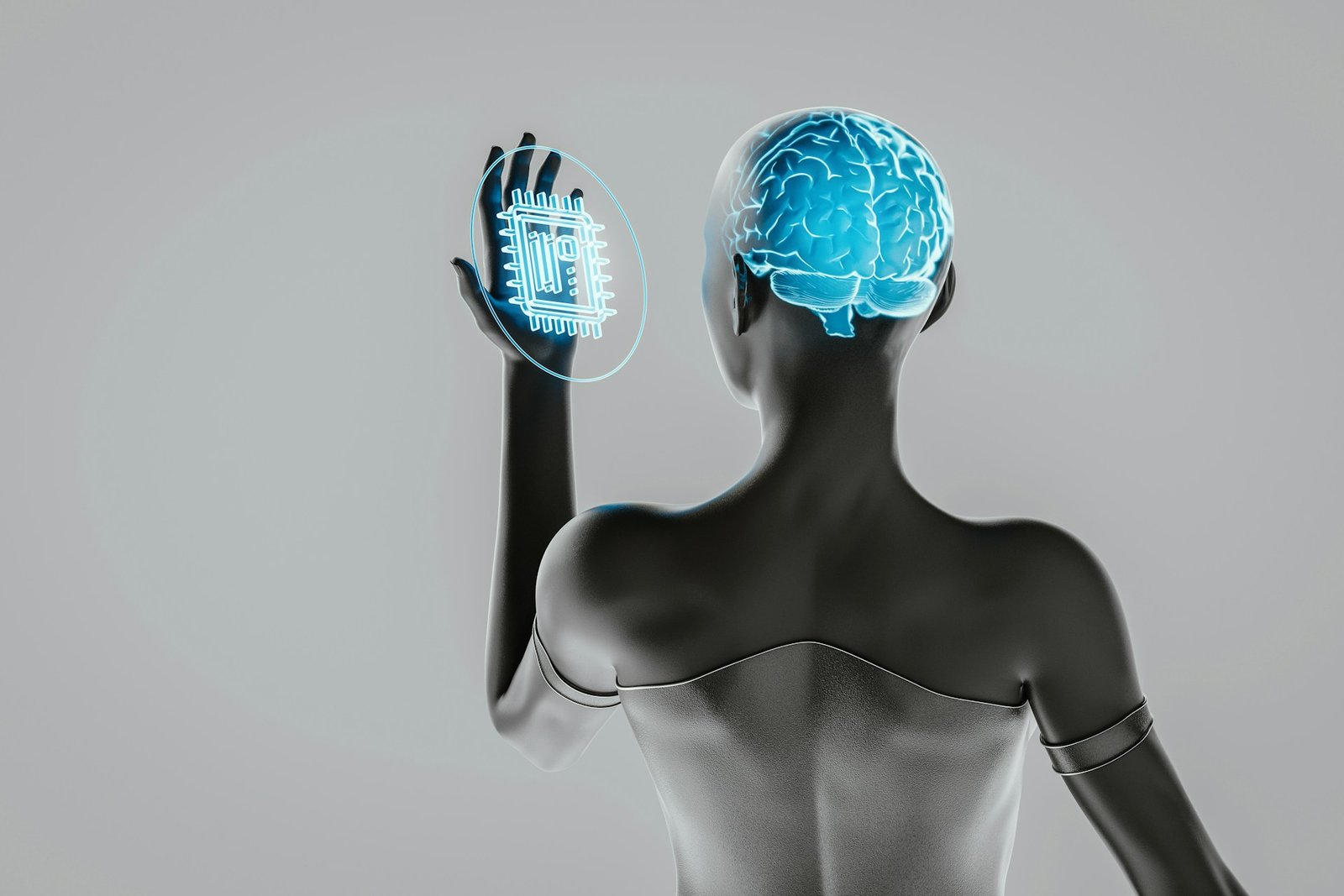
Diciamo le cose come stanno: l’intelligenza artificiale generativa è la figlia legittima dell’abbondanza e del mainstream.
E non mi riferisco alla conoscenza in se stessa, bensì al suo accumulo: testi che sembrano infiniti, ridondanze statistiche, reiterazioni di ciò che è stato ampiamente detto e ri-detto nel mondo occidentale.
In realtà, questa abbondanza è un inganno, nel senso che… la voce dell’AI è sicura perché attinge a nozioni, idee, costrutti e fatti ripetuti fin troppe volte.
Eppure – come dicevo nello scorso articolo – la mappa che è tracciata a partire dal centro è, inevitabilmente, incompleta.
A mancarle sono i margini bianchi, le periferie geografiche, culturali e linguistiche che, mano a mano, si allontanano dalla cultura occidentale.
Pensa. Cosa accadrebbe se l’intellligenza artificiale fosse addestrata nelle periferie dell’impero, lontana dal centro di accumulo compulsivo di dati?
Ragionando a converso, più ci si allontana dal centro, più la sua realtà, il suo ‘sapore’ si rarefanno. E, a una certa distanza, di quella enorme quantità di informazioni residuerebbe una piccola concentrazione.
La logica è la stessa della distribuzione delle risorse nel mondo: man mano che ci si allontana dai grandi centri di potere politico-economico e finanziario le risorse vengono a mancare finché, nelle periferie del mondo, si sopravvive con poco.
Ecco, io non se né ‘se’ né ‘quanto’ possa essere interessante, ma sono davvero convinta di un fatto : se l’AI fosse addestrata nelle periferie del mondo, sarebbe guidata dal principio della scarsità.
Di più.
La scarsità vedrebbe se stessa elevata al rango di metodo cognitivo.
Passo a spiegarmi ( spoiler: oggi ti porto completamente dentro a uno dei miei ‘percorsi’ mentali. Ti tocca).
⚡ La scarsità è una forma di intelligenza?
Nelle periferie del mondo, la scarsità non ha a che fare con le categorie concettuali. Lì, è una reale condizione materiale.
Libri pochissimi, connessione internet scarsa, pochi strumenti.
In queste aree della Terra, non si accede alla cultura per accumulo, ma per frammenti.
Però, questo, non deve fuorviarci: sul lungo periodo, la ‘scarsità’ di mezzi non produce povertà di pensiero così come l’abbondanza (per esempio, nella porzione di Terra che abitiamo noi) non è garanzia di eccelsa qualità di pensiero.
Se, spesso, l’abbondanza fa rima con ‘ridondanza’, la scarsità costringe a selezionare ciò che utile da ciò che non lo è, ciò che è efficace da ciò che non lo è.
In altre parole, così come la scarsità di risorse materiali (cibo, acqua, etc.) costringe alla loro razionalizzazione e alla selezione dei destinatari – giungendo a performare il bilancio di distribuzione di quelle risorse stesse – così la scarsità degli strumenti culturali compie un’analoga selezione con l’unica differenza che il bilancio performabile è quello della raffinatezza e della precisione del pensiero.
Sin può dire che la scarsità sia il volano di una pedagogia della qualità?
Forse. Basti pensare all’impatto che la Seconda guerra mondiale ha prodotto nel pensiero italiano post-bellico.
Ma, comunque la si veda sul piano dell’analisi e delle categorie, la scarsità degli degli strumenti tecnici di apprendimento ha un riflesso sul piano linguistico assolutamente non trascurabile: la lingua diventa più asciutta e punta dritta alla densità semantica.
Se, da un punto di vista cognitivo, diventa – come accennavo sopra- un esercizio di distinzione (ciò che vale, ciò che conta, ciò che sopravvive rispetto al trascorrere del tempo), sotto il profilo epistemologico la scarsità ci mette di fronte ‘al fatto compiuto’ che la conoscenza non è questione di quantità e che il pensiero non cresce per accumulo, ma per scelta [1].
È un metodo di intelligenza?
Penso di sì.
⚡ Economia linguistica come segno di etica
“La terra da cui siamo germogliati,
quella terra annerita dalla storia,
rimasta nuda —
ha cercato un senso,
e si è persa in un’onda di probabilità.
Il silenzio parla.
Dice ciò che non osiamo dire,
tiene in sé la memoria di chi non ha voce.
Ogni pausa è un nome non pronunciato,
ogni respiro una domanda che non trova ascolto.
Il silenzio parla.
Nel suo vuoto ci sono tracce,
ombre di parole che non hanno trovato spazio.
Eppure, proprio lì, nel non detto,
inizia di nuovo la lingua.”
Questa che hai appena letto è la voce della poetessa nigeriana Élé Apeh, pubblicata sulla rivista panafricana The Kalahari Review [2].
La sua poesia “Il silenzio parla” filtra e condensa, in poche parole, tutto ciò che l’abbondanza linguistica dimentica: la misura, la memoria, il potere del non detto
È solo un esempio (avrei potuto menzionare la poetessa iraniana Forugh Farrokhzad, il brasiliano João Cabral de Melo Neto o il nigeriano Niyi Osundare) che dimostra, in forma poetica, ciò che la riflessione etica e linguistica della scarsità afferma in teoria: il silenzio e la scarsità non sono un difetto del linguaggio, ma una tra le sue soglie più alte.
Nelle periferie, dove ogni parola costa fatica, la lingua si misura con la responsabilità del dire.
In questa misura — non nei fasti della notorietà — si riconosce la sua dignità.
E questa è la ragione per cui la scarsità diventa etica.
Perché non è solanto una questione di ridurre, sfrondare l’eccesso, ma di scegliere con cura ben sapendo che ogni parola dal peso eccedente l’intenzione di chi la pronuncia è da evitare.
Una parola in più può significare malinteso, rottura, conflitto. Una parola in meno è un gesto di prudenza mista ad ascolto, rispetto e attesa finalizzata a riflettere.
Dal punto di vista linguistico, l’economia è sinonimo di precisione: saper calibrare la parola a seconda del contesto fa parte delle abilità politiche che Hermes, su comando di Zeus, conferì all’Uomo salvandolo dalle conseguenze dell’errore commesso da Epimeteo.
Dal punto di vista cognitivo, significa disciplina: educare la mente a non confondere tra ‘abbondanza’ e ‘profondità’.
Dal punto di vista politico, significa responsabilità: riconoscere che il linguaggio non è neutro, bensì partecipa alla costruzione o alla distruzione dei legami sociali.
E mai come oggi abbiamo toccato con mano quanto sia vero.
⚡ E in rapporto all’addestramento dell’AI?
Se l’AI fosse addestrata dalle voci delle periferie, guadagnerebbe questa sobrietà. Imparerebbe a
🔹 comprendere che la scarsità è un metodo del pensiero
🔹 ridurre l’eccesso informativo,
🔹 accettare l’incompletezza,
🔹 restituire profondità invece di riempire ogni spazio.
°°°°°
So di stare pattinando su un terreno accidentato dal momento che, per l’AI, tutto è noumeno e niente è fenomeno. Ma questo non toglie che:
a) la voce dell’intelligenza artificiale nasce dal mainstream e dall’eccesso: di dati, di parole, di versioni di mondo. La sua è un’intelligenza figlia del troppo.
b) sebbene non possa farlo direttamente, l’Uomo può avvicinare l’AI all’esperienza del limite.
Perché a essere rilevante non è ciò di cui l’AI non dispone, ma ciò che non sa riconoscere.
Lei non sa pesare una parola (del resto, le distribuisce secondo un criterio probabilistico mica secondo necessità).
E non sa neppure tacere al momento giusto, perché il suo scopo è riempire spazi di contenuto, non custodire senso.
Se fosse addestrata dalle periferie della Terra ( quelle verso cui, spesso, l’Occidente bianco, specialmente anglofono inseguito da quello latino, prova un senso di disagio quando non di disgusto) l’AI conoscerebbe nuovi linguaggi, certo, ma soprattutto, imparerebbe la logica della fame, dell’attesa, del poco.
E, forse – chissà-, a quel punto sembrerebbe pure capace di pensare.
[1] Prova a leggere le poesie di Tahar Ben Jelloun, di Hamid Barole Abdou o di Jaime Saenz: proverai e, allo stesso tempo, comprenderai qualcosa di importante.
[2] puoi trovarla qui
_____________________________
Se anche tu credi che la vera sfida dell’AI non sia generare di più, ma dire meglio, restiamo in dialogo: https://katiabovani.it/contatti/. Il futuro del linguaggio si costruisce parola per parola